
Roma, 22 ottobre 2019, Nena News – “Inciampo, non appena cammino lentamente” è l’unica raccolta di poesie di Jumana Mustafa, tradotta in italiano fino ad oggi. Poetessa e giornalista, nata nel Kuwait da una famiglia palestinese nel 1977, oggi vive in Giordania.
I suoi versi mi hanno condotto delicatamente, dondolandomi, in un viaggio lieve diretto verso il profondo, in un percorso fatto di immagini surreali eppure così radicato nel vissuto quotidiano. Mi hanno attratto le assonanze delle sue parole che rimangono sempre leggere, in alcuni momenti ironiche, in altri pungenti, in altri ancora meravigliosamente irriverenti.
Come scrive Aldo Nicosia nella prefazione del libro, “l’autrice è stregata dalla magia delle assonanze e degli accostamenti inconsueti delle parole che creano immagini intense e dense. Così dense da poter esser scolpite. La sua penna a volte si trasforma in scalpello che estrae, dalla materia informe dell’immenso dizionario arabo classico…”
Inciampo / non appena cammino lentamente / proprio come accade a tutte quelle donne / ritrovate / nei giacigli della delusione / i capelli rasati / le vene recise /
Non fermarti presso chi rassomiglia al tuo sogno / non seguire le frecce che conducono alla verità / la verità si trova dall’altra parte…
Perché. Sono prorompenti i perché che le parole dell’autrice fanno emergere. Cosa genera più dolore per Jumana, inciampare? O camminare lentamente? In che modo la poesia interviene in questi giacigli della delusione in cui si “ritrovano” donne dai capelli rasati e le vene recise? È dunque la velocità una salvezza? O forse un inganno? E da cosa ci salverebbe, dal non inciampare? O forse da noi stesse, dalle nostre paure, dai nostri pensieri più intimi?
Oppure ancora la velocità ci salverebbe omologandoci ai ritmi frenetici di un sistema nel quale annientarci, ci salverebbe da un mondo esterno che ci chiede di annullare il nostro diritto alla lentezza, il nostro diritto di camminare in un percorso intimamente nostro?
Eppure è fondamentale il diritto di tutte noi di “inciampare” e di “camminare lentamente”. Ogni donna dovrebbe muoversi secondo ritmi propri, ritmi femminili più dilatati, dettati per esempio dai tempi della riproduzione e non secondo frenetici ritmi maschili dettati dai tempi della produzione. La giornalista Anna Del Bo Boffino negli anni ’80 spiegava che i ritmi della riproduzione, propri della sfera femminile, hanno dovuto adeguarsi e rimanere costretti dentro ai ritmi della produzione, propri della sfera maschile.

Ovviamente non può esserci alcuna produzione senza riproduzione, ma questo è un altro discorso. Oggi i versi di Jumana mi hanno riportato al diritto di “camminare lentamente” anche se ci fa inciampare in noi stesse e nelle nostre paure.
È una poesia profondamente libera quella di Jumana Mustafa. Anche nella forma. Nessun titolo per le sue qasida, nessun ordine precostituito è autorizzato a imprigionare i suoi versi che spaziano liberi, liberi dall’essere vincolati ad un unico significato, liberi di immergersi nel più profondo dell’animo umano e soprattutto nell’immenso animo femminile, liberi di essere scanzonati e di sbeffeggiare con leggerezza il sistema partendo dal proprio intimo, liberi di infilarsi in linguaggi assolutamente indipendenti e diversi da quelli propri dell’ortodossia femminista o delle battaglie di autodeterminazione dei popoli arabi.
Di nuovo Aldo Nicosia, nella sua prefazione, ci ricorda che “Jumana definisce la sua poesia di un “coraggio tranquillo”, mai rumoroso, mai ribelle. I suoi versi vedono lontano, ma non hanno orecchie da prestare ai vacui gemiti del mondo”.
Come non rimanere incantate dalla poesia di Jumana Mustafa e dalla sonorità dei suoi versi in arabo? La incontriamo a Salerno il 24 ottobre, ospite della rassegna Femminile palestinese, che curo dal 2014 con la promozione del Centro di Produzione teatrale Casa del Contemporaneo. Insieme a lei Omar Suleiman che ha curato la pubblicazione della sua raccolta a Napoli nel 2011 (libreria Dante Descartes), con la traduzione di Bianca Carlino.
Come nella tradizione di Jumana Mustafa, che ama coniugare il teatro alla poesia, ho voluto organizzare l’incontro presso il teatro Ghirelli di Salerno con una presenza musicale. Con noi infatti il gruppo Hartmann Quartett: Daniele Apicella – tamburi a cornice e percussioni. Renata Frana- dilruba. Gabriele Pagliano – contrabbasso, viella. Carlo Roselli – citola, oud, robab, voce.
Nessun confine, quindi, fra le varie discipline artistiche che si fondono in un unico e denso incontro con Jumana Mustafa. Vi aspetto e vi saluto con i suoi versi:
Cadere una sola volta / basta per rendere zoppa la vita /
Avere un solo cuore / basta per amarti, vita zoppa.
* curatrice della rassegna Femminile palestinese
***
BIOGRAFIA
Jumana Mustafa, nasce nel Kuwait nel 1977 da una famiglia palestinese, vive in Giordania dove ottiene la cittadinanza nel 2004. Lavora come corrispondente per diversi quotidiani, tra i quali il giordano Al Ghad nella sezione culturale.
Nel 2008 entra nella compagnia teatrale Al Fauanees con cui istituisce il Festival Poesia in teatro, che si svolge annualmente. Si dedica alla poesia sin dall’infanzia e pubblica tre raccolte “Estasi Selvaggia” Dar al-Farabi, 2007, “Dieci donne”, Arab Institute for Research and Publiscing, 2009, “Una bellezza defunta vincerà la scommessa” Dar al-Farabi, 2011.
Partecipa a diversi festival internazionali di poesia e teatro in Italia, Siria, Tunisia, Algeria oltre che a numerose serate poetiche a Damasco, Amman e Beirut. Attualmente lavora presso la UNDIP di Amman come responsabile del settore comunicazione e informazione.
La traduttrice Bianca Carlino (Palermo 1984) ha studiato la lingua araba nelle università di Tunisi, Palermo e Napoli . Ha tradotto in italiano alcune opere di Maram al-Masri.
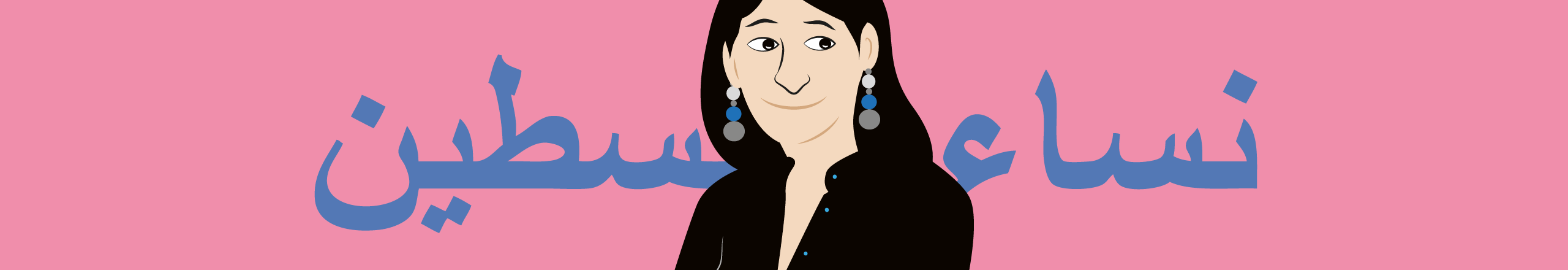







 Roma, 26 febbraio 2018, Nena News – “Palestina, decolonizzazione, libertà accademica” è il tema dell’incontro con cui ritorna la rassegna Femminile palestinese, quest’anno alla quinta edizione. Il 2018 inizia con la presenza dello storico israeliano Ilan Pappe (University of Exeter) e dell’antropologa italo-palestinese Ruba Salih (SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London) il 2 marzo 2018, alle ore 10.30, presso l’Aula Vittorio Foa del DSPSC (Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione) dell’Università di Salerno. Con loro intervengono Giso Amendola, Sociologia del diritto (Università di Salerno) e Gennaro Avallone, Sociologia urbana (Università di Salerno). L’incontro è aperto a tutti.
Roma, 26 febbraio 2018, Nena News – “Palestina, decolonizzazione, libertà accademica” è il tema dell’incontro con cui ritorna la rassegna Femminile palestinese, quest’anno alla quinta edizione. Il 2018 inizia con la presenza dello storico israeliano Ilan Pappe (University of Exeter) e dell’antropologa italo-palestinese Ruba Salih (SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London) il 2 marzo 2018, alle ore 10.30, presso l’Aula Vittorio Foa del DSPSC (Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione) dell’Università di Salerno. Con loro intervengono Giso Amendola, Sociologia del diritto (Università di Salerno) e Gennaro Avallone, Sociologia urbana (Università di Salerno). L’incontro è aperto a tutti.